(DISCLAIMER: Non sono in alcun modo qualificata per parlare a nome della comunità nera. Questo articolo è basato rigorosamente su conversazioni con individui di questa comunità e mie ricerche e documentazioni sul seguente argomento che ha contribuito a formare la mia opinione sulla materia.)
Il detto “Un’immagine vale più di mille parole” viene popolarmente attribuito a Confucio, il quale visse nel 500 a.C. Se Confucio si svegliasse oggi e prendesse in mano un qualunque smartphone, si accorgerebbe che oggi più che mai le sue parole rispecchiano la realtà. Oggi, infatti, che una sequenza di immagini riceva più attenzione e likes, rispetto a contenuti scritti, ha cambiato lo scopo e il significato apparente di informazione: stupire, in positivo e in negativo. Se si considera poi la sovrabbondanza di contenuti, appare chiaro come da questo risulti una tendenza a utilizzare immagini sempre più forti, crude e con il maggior impatto emotivo, indipendentemente da possibili ripercussioni sugli spettatori.
Bambini sofferenti e senza cibo, i cui video appaiono durante le pause pubblicitarie, live di sparatorie e attentati, pestaggi dove nessuno interviene ma di cui si trovano riprese da più angolazioni, edifici e ponti che crollano inaspettatamente, porti che esplodono, uccisioni e violenze da parte di poliziotti su civili pacifici, proteste che vengono represse con violenza e barconi ribaltati. Di questo fenomeno è particolarmente emblematico un video che ha recentemente fatto scalpore, soprattutto sui social media.
A questa tipologia di contenuti può essere ricondotto buona parte del materiale a cui siamo esposti quotidianamente, attraverso i media tradizionali e soprattutto attraverso quelli nuovi. Dato il loro grande impatto emotivo, le nostra capacità di assorbire e metabolizzare questo tipo di contenuto in modo consapevole diminuisce, e, per non essere sopraffatti, come meccanismo di difesa, diveniamo sempre più apatici. Come riporta il New York Times, “Per alcune persone, potrebbe non essere importante il mezzo attraverso il quale consumano le loro notizie: un video è un video e un articolo un articolo, sia che si tratti di uno schermo TV, di un laptop o di un giornale. Ma ci sono diversi motivi per sospettare che l’impatto emotivo di tali immagini intime sui social media o notizie derivate da Internet sia diverso, e forse anche più duraturo in alcuni casi, rispetto a quello delle fonti dei vecchi media. Il contatto con la violenza attraverso qualsiasi media può portare a quello che viene chiamato traumatizzazione indiretta e, per alcune persone, può essere più sconvolgente di un’esperienza non mediata”. Lo studio presentato al 2015 Annual Conference of the British Psychology Society da Pam Ramsden, docente di psicologia alla University of Bradford, mostra infatti come i social media, a differenza dei mezzi di informazione tradizionali, hanno “permesso al pubblico di guardare storie violente e immagini grafiche con dettagli orribili inediti”, dove spesso questi contenuti non sono preceduti da messaggi di avvertimento riguardo al materiale.
La motivazione più comunemente usata per la condivisione di certi contenuti sui social media è il quella di sensibilizzare o su un certo tema. Con Rose Mutombo, parte di Black Lives Matter di Rovigo, proprio di questo, ovvero di quella linea molto sottile tra sensibilizzazione e mera condivisione di contenuti grafici. Per la prima non è necessaria la condivisione di contenuti espliciti per far vergognare chi le guarda. “Tantissime volte queste immagini vengono condivise e c’è una didascalia come ‘ma in che mondo viviamo’, ‘ma io mi vergognerei’, non è sensibilizzazione questo, è far sentire in colpa la persona che lo guarda”. Per Rose non è una questione di colpevolezza l’aver condiviso contenuti del genere, ma dell’essere vittime del mondo social. Mi parla di come spesso si senta il bisogno di un fattore shock sui social in modo da attirare l’attenzione, ma “il problema è quando questo fattore shock riguarda la vita di altre persone soprattutto quando riguarda vite nere o di minoranze”.
Mia-Simone Green è una studentessa di psicologia Presso la Georgia State University, è particolarmente interessata alla teoria ed analisi critica e a come la psicologia può essere implementata nelle analisi strutturali di gruppi e organizzazioni. Durante un TEDx (Technology Entertainment Design è una serie di conferenze, gestite dall’organizzazione privata non-profit statunitense Sapling Foundation, TEDx sono eventi indipendenti che si riferiscono alla casa madre ma non coinvolgono la sua diretta organizzazione) porta avanti la definizione di Trauma Porn: una fascinazione del piacere voyeuristico di immagini traumatiche, sotto questa idea che il consumo di media violenti diventa una via per la feticizzazione del piacere voyeuristico della sofferenza. “Non solo il trauma porn consente agli spettatori di tali mezzi di comunicazione di disumanizzare le vittime di violenza, mercificando le vittime. Ma desensibilizza anche gli spettatori”. quest’ultimi hanno un’opportunità di interagire virtualmente senza subire violenza e senza dover far fronte alle gravi conseguenze di quella violenza, dileguando e minimizzando la sofferenza e sfruttando il loro trauma. Nora Berenstain, professoressa di filosofia l’Università del Tennessee presso rigetta a sua volta la condivisione di contenuti violenti come informazione, introducendo il tema dello sfruttamento epistemico, ossia quando persone privilegiate costringono persone marginalizzate a produrre fonti di educazione o una spiegazione del trauma che devono affrontare e li obbliga a rivivere esperienze traumatiche in cambio di lavoro emotivo non compensato.
“Nell’arco di pochissimo tempo abbiamo visto Afroamericani a cui hanno sparato e malmenato per strada, abbiamo visto immigrati morire nel mediterraneo, abbiamo visto gente morire di fame nello Yemen. Tutto questo nel mezzo di una pandemia globale”, Rose continua dicendo che queste cose ci sono sempre state, perché allora ora c’è bisogno di una prova così forte per far sì che la gente si renda conto che queste cose stanno succedendo?. “Il fine della sensibilizzazione è giusto, ma i modi sono sbagliati”, perché da un lato veder finalmente parlare di temi come la SARS e le miniere di cobalto in Congo, per Rose e suoi conoscenti che in quanto Congolesi e Nigeriani erano già a conoscenza delle situazioni, era estremamente positivo, ma dall’altra parte provano un turbamento e una stanchezza nell’aprire i social e vedere persone del loro paese d’origine in quei video e foto.
“Io ad un certo punto ho dovuto smettere di usare i social”.
Condividendo stiamo avendo quindi l‘effetto opposto di quello che vorremmo: “stiamo diventando più passivi ovvero dopo un po’ diventa una corsa normale”, lo shock della notizia è abbastanza forte da catturare la nostra attenzione per abbastanza tempo da farci pensare che ci importi di questa tematica, ma troppo poco per farci qualcosa a riguardo. Eppure opzioni anche semplici per essere attivamente partecipi alla sensibilizzazione ci sono, Rose mi fa vari esempi, dal condividere link di associazioni responsabili agli aiuti, visitare centri di accoglienza come volontari “anche solo per parlare” e ascoltare, per chi ha le risorse economiche per farlo ci sono associazioni a cui donare o raccolte di sostegno come quella per i prodotti igienici femminili.
Si parla sempre di condividere e quindi si arriva a pensare che basti farlo, con l’idea che un’immagine valga più di mille parole. Ma non vale più della nostra sanità mentale, e non vale quanto reale informazione e azione.
-Chiara Migliari

FONTI:
https://www.nytimes.com/2016/09/11/fashion/the-trauma-of-violent-news-on-the-internet.html
https://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1237&context=philosophy_theses https://www.istat.it/it/files/2020/06/REPORT_PARTECIPAZIONE_POLITICA.pdf
Rethinking Trauma Porn | Mia-Simone Green | TEDxGeorgiaStateU

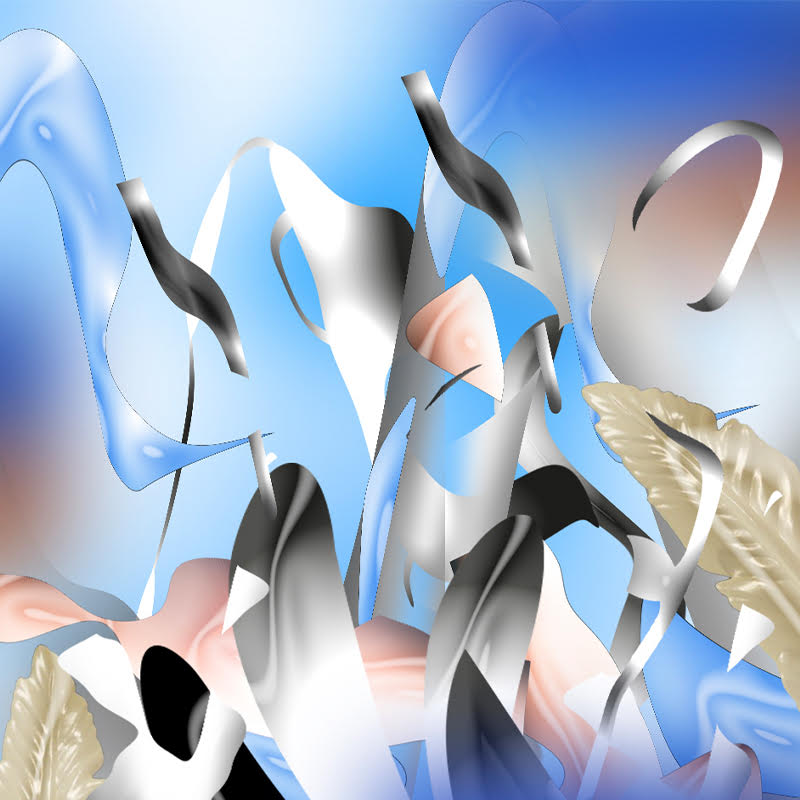
Rispondi